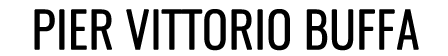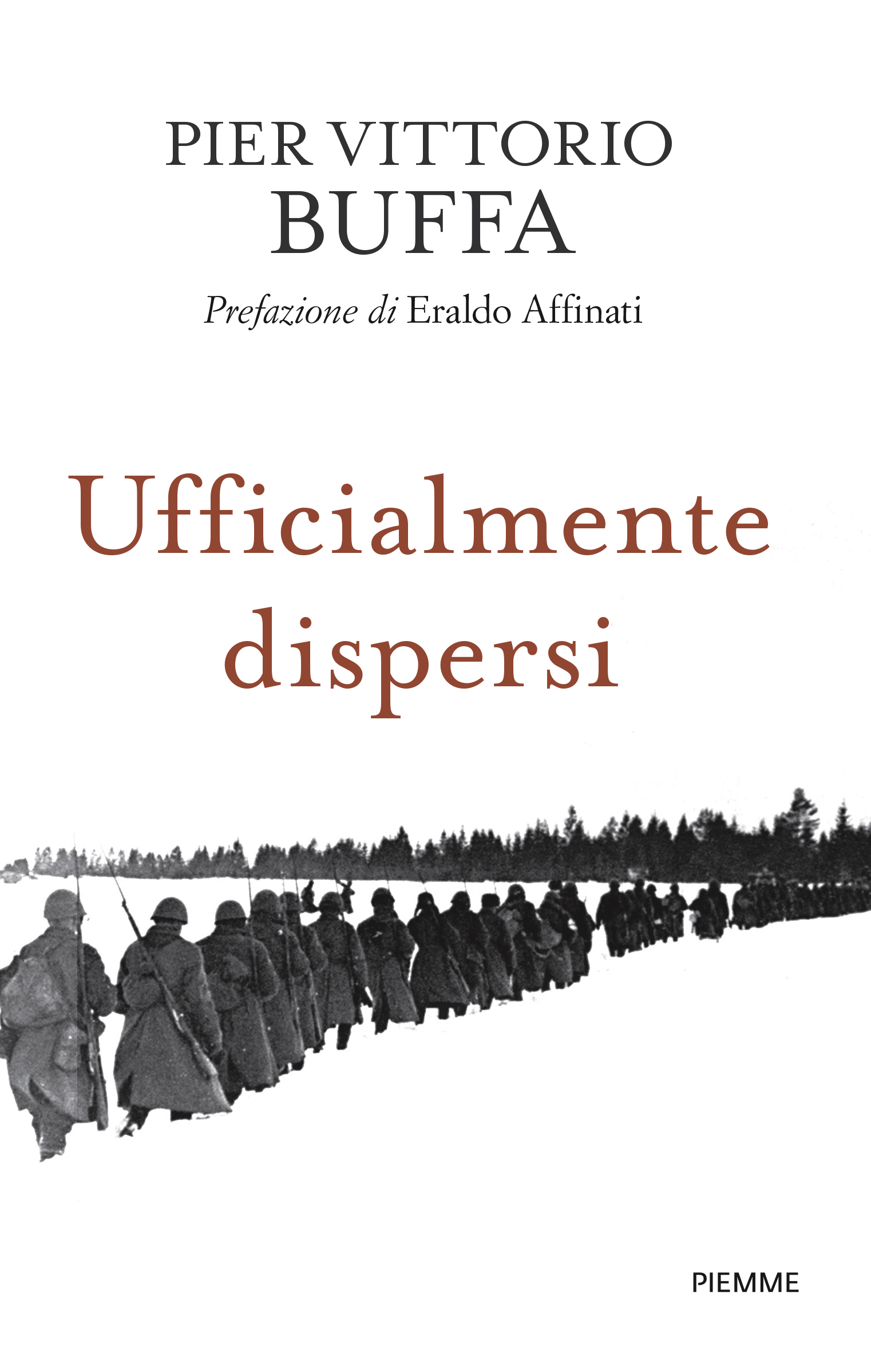Ricordo il giorno in cui Mario Rigoni Stern, indimenticabile testimone e scrittore della ritirata di Russia, durante una piccola sosta del nostro cammino verso Porta Manazzo, nell’Altopiano di Asiago, mi disse: «Vuoi sapere quale è stata la mia vittoria più bella? Non pensare ai libri che ho pubblicato, ai premi che ho vinto». Guardandomi fisso negli occhi il vecchio sergente scandì lentamente: «La mia soddisfazione maggiore è stata quella di aver riportato a casa gli uomini che mi erano stati affidati».
Conoscevo quel concetto: il grande vecio lo aveva già espresso più volte e anche dopo sino alla fine della sua avventurosa esistenza spesso lo ribadì nelle interviste ufficiali in una risonanza profondamente leviana, pensando soprattutto a I sommersi e i salvati, capolavoro della memoria allo stesso tempo lucida e sfigurata, perché forse soltanto gli scomparsi avrebbero avuto il diritto di raccontarci l’abominio in cui furono coinvolti: non potendolo fare hanno consegnato ai sopravvissuti una speciale responsabilità. Tuttavia sentirlo proclamare in quel modo dall’autore del Sergente nella neve, in grado di incarnare come pochi ciò che esclamava, mi colpì nel profondo. E ovviamente ripensai alla reiterata domanda che nel suo straordinario romanzo l’ingenuo e sventurato Giuanin, camminando nel gelo sotto i colpi dell’artiglieria avversaria, non si stanca di rivolgere al sottufficiale: «Sergentmagiù, ghe rivarem a baita?».
Leggendo Ufficialmente dispersi di Pier Vittorio Buffa, mi sono tornate in mente quasi a ogni pagina, alla maniera
di un refrain, le parole di Mario e le invocazioni dell’alpino, in quanto il protagonista di questa storia, sottotenente al comando di un pugno di uomini nelle fasi cruciali del ripiegamento italiano durante la disastrosa campagna di Russia ordinata dal Duce, vede scomparire di fronte ai suoi occhi, nel corso di uno scontro a fuoco a distanza ravvicinata coi sovietici, quattordici soldati: al maggiore che gli chiede quale fine avessero fatto, non sa cosa rispondere. L’unica certezza è che non sono tornati a baita. Il resoconto militare non basta a frenare il tumulto interiore del protagonista. Egli si sente chiamato in causa da un’entità indecifrabile, non esattamente riconducibile al grado che ricopre. Da quel momento in poi, anche dopo essere stato rimpatriato e aver ripreso la vita civile, non riuscirà a pensare ad altro: «Non aveva visto morire i suoi soldati, ma gli sembrava di essere stato lui a ucciderli: per non averli difesi, per non averli riportati indietro, per non essere tornato a prenderli».
Conoscere il destino dei suoi sottoposti si trasformerà in una speciale ossessione: ipotesi da vagliare, ricerca delle fonti, missive da scrivere ai parenti, argomenti da studiare, fantasmi da affrontare. Del resto, al termine della guerra, fra morti e dispersi, sul fronte russo si conteranno quasi ottantamila uomini. Molto spesso erano ragazzi di vent’anni. Ognuno aveva un suo mondo di affetti che, immediatamente dopo la sconfitta, chiese udienza e piegazioni. Il 22 gennaio 1943, giorno della battaglia perduta, diventa quindi il più importante nella vita del reduce. A ogni anniversario, decide di andare a messa bisbigliando, insieme al padrenostro, il suo particolare contrappello: «Il sacerdote pronunciava le frasi in latino, che pochi comprendevano e tutti ripetevano. Il Sottotenente elencava i nomi dei quattordici soldati del plotone. Lo faceva muovendo appena le labbra perché nessuno accanto a lui si accorgesse che le parole che pronunciava dentro di sé erano fuori tempo con quanto accadeva nella chiesa. Continuò così a lungo: cognome e nome, cognome e nome».
L’opera che avete fra le mani non è solo un testo di guerra, peraltro ambientato negli stessi luoghi del recente conflitto russo-ucraino: le descrizioni belliche, precise e cruente, compreso un violento corpo a corpo, si limitano ai capitoli iniziali, anche se riaffiorano in seguito nella mente talvolta alterata del personaggio principale alla maniera di allucinazioni. Siamo piuttosto di fronte a una riflessione sulla natura degli eventi traumatici quale sostrato della nostra identità: certe cose non si possono dire, certo non ai parenti più stretti. Neanche alla moglie. Nemmeno al figlio che pure, da adulto, quando nel 1979 a sua volta si sposa e diventa padre, decide di prendere l’iniziativa assemblando in modo espressivo i diari del genitore. Allora i volti dei combattenti prendono forma nel carattere italiano: Mario, Renato, Giovanni, Guido, Antonietto… «Uno per uno, con il nome, la piccola storia personale, le qualità, i difetti, le manie, le speranze.»
Esistono fratture interiori che, per essere saldate, hanno bisogno di più generazioni. Come il sasso lanciato nel lago stagnante che, nell’istante in cui sprofonda, produce numerose onde concentriche. Al Sottotenente è toccato in sorte un groviglio spinoso irrisolto: gran parte del racconto coincide con lo scrutinio delle sue pazienti, ansiose, ostinate, cocciute investigazioni: cinquant’anni a inseguire la sorte dei quattordici caduti per poterla almeno comunicare ai congiunti. Chiudere i conti non sarà possibile. Tante sono le questioni sospese. E se, ad esempio, quei coscritti mandati allo sbaraglio l’avessero scampata e magari fossero vissuti nell’anonimato di qualche condominio alla periferia di Karkov, come forse era accaduto a un tal Campalto di Campolongo Maggiore, provincia di Venezia, di cui avevano parlato i giornali? Fra l’altro su questo tema Vittorio De Sica girò nel 1970 con Sophia Loren e Marcello Mastroianni un film suggestivo come I girasoli.
Alla fine le risposte arrivano, ma non sono sufficienti a placare l’inquietudine delle persone coinvolte, le quali appartengono alle più diverse età, fra protagonisti diretti e loro consanguinei, anzi talvolta basta una notizia di cronaca per esacerbare di nuovo gli spiriti infiammati. Nel sacrario di carta di un archivio capitolino, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, qualche scheda salterà comunque fuori, ma non comporrà i dissidi, non sanerà i contrasti, non asciugherà le lacrime delle antiche madri, delle vecchie fidanzate. Sapere che molti dei quattordici dispersi vennero fatti prigionieri dai russi e morirono pochi mesi dopo nei campi di lavoro o, come nel caso di Nino, nel corso di una pazza fuga, potrà semmai riaprire nei figli le vecchie ferite.
Pier Vittorio Buffa, ispirandosi alla storia di suo padre ma trasfigurandola, ha ottenuto un risultato di grande intensità: stilistica innanzitutto, per la capacità di trattamento del materiale incandescente di cui disponeva. Si ammira il dosaggio delle fonti, distillate come gocce di sangue nella struttura in parte diaristica dell’elaborato. Lo scrittore sa conquistarsi una distanza oggettiva dai fatti che, se non filtrati, lo avrebbero trascinato nel gorgo. Ed è proprio tale progressiva decantazione dell’esperienza diretta a rappresentare al meglio l’esito letterario, senza raffreddare il contenuto tematico, che mantiene sempre un alto tasso emotivo.
Dopo la prima pubblicazione, avvenuta nel 1995, Ufficialmente dispersi, che venne riedito nel 2010, conferma oggi di essere un’opera fondamentale fra quelle composte dalle cosiddette “seconde generazioni”. Resta negli occhi la vicenda triste e sconsolata dei sommersi – «Probabilmente erano stati tutti sepolti nelle fosse comuni accanto al campo e nel prossimo futuro, per quel che aveva saputo, sui luoghi dei ritrovamenti sarebbe stata posta una lapide in memoria» – specie a chi, come me, vent’anni fa vide coi propri occhi i poveri resti di quei soldati nei cimiteri russi vicini al Don: mucchi d’ossa gettati alla rinfusa da improbabili becchini nei sacchi di plastica che usiamo per l’immondizia. Ma nelle pagine che seguono a pulsare è soprattutto il cuore del protagonista: inesausto insoddisfatto cercatore di giustizia e sapienza. L’Epilogo è, in tale direzione, una vera scudisciata perché deposita nella coscienza del lettore una drammatica consapevolezza: alcune verità sono destinate a restare inattingibili, nascoste come reliquie nell’animo di chi le ha vissute.
Eraldo Affinati